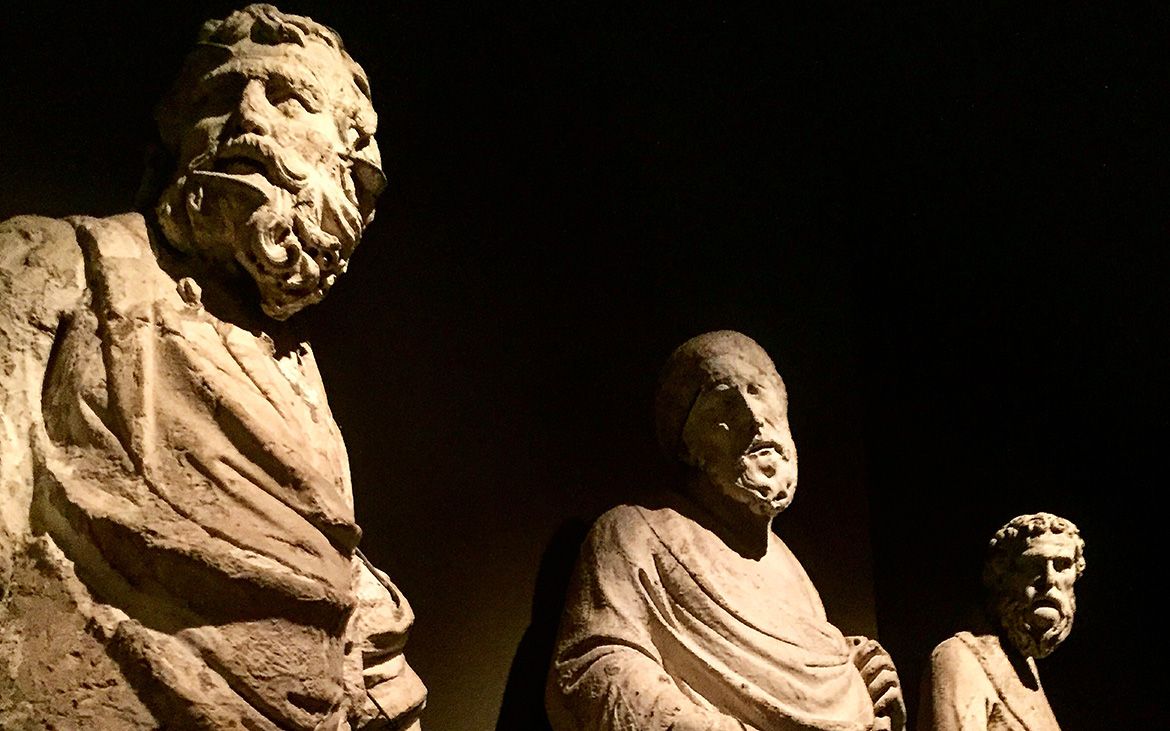La città di Siena
L’utopia gotica
Approfondimenti

Il Palio di Siena
Il Palio non è una manifestazione rievocativa a scopo turistico: è parte integrante della vita del popolo senese e coinvolge molti aspetti sociali, economici e culturali della città. Ha origini molto antiche, alcuni regolamenti, ancor oggi validi, sono in vigore dal 1633, anno in cui è documentato con certezza che venne corso il primo Palio così come ancora avviene, in continuità mai interrotta (ad eccezione del periodo delle due guerre mondiali del XX° secolo).
Il territorio della Città è diviso in diciassette Contrade con dei confini stabiliti nel 1729 da Violante di Baviera, Governatrice della Città. La "carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si svolge normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano festa della Visitazione nella forma straordinaria, e il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta. Ogni Contrada è come un piccolo stato, governato da un Seggio con a capo il Priore e guidato nella "giostra" da un Capitano, aiutato da due o tre contradaioli detti "mangini" o "tenenti". Nel territorio di ogni Contrada c’è una Chiesa, detta "Oratorio", con limitrofa la sede ufficiale, dotata di un Museo, ove viene custodito tutto il patrimonio di contrada: cimeli, drappelloni delle vittorie, costumi della Comparsa, sia quelli in uso che anche quelli antichi dismessi, bandiere, archivio e tutto quello che riguarda la storia e la vita della Contrada stessa. La presenza del Palio nella storia senese è quasi millenaria. Addirittura nel 1200, si hanno testimonianze di corse con i cavalli e addirittura documenti anteriori al XII secolo citano un Palio di San Bonifazio, il santo titolare dell’antica Cattedrale, a cui era intitolato il precedente Duomo ora dedicato alla Vergine Maria. Questi primi Palii furono disputati dai nobili. Le Contrade partecipavano, invece, a giochi più cruenti le cui grandi masse di contendenti si opponevano su base territoriale. Siena, infatti, era nata su tre colli, e le Contrade presero vita e forma all'interno di questa tripartizione. La più antica memoria d'archivio delle Contrade è nel regolamento del 1200, dove si prescrive che tutti i cittadini rechino il cero in Cattedrale «cum hominibus sue contrate». Le Contrade furono assai più numerose delle attuali: dopo la peste del 1347, il loro numero si ridusse a 42. Presero i loro nomi da strade, porte o fonti, chiese o da illustri famiglie residenti nel loro territorio. Ebbero funzioni devozionali, amministrative, militari e ricreative. Nel corso del Medioevo e durante il Rinascimento si organizzavano molte corse; nobili signori, notabili, cittadini senesi ed anche forestieri portavano i loro migliori cavalli per i giochi, che si svolgevano per onorare le feste di santi o per celebrare la ricorrenza di speciali eventi. Una di queste corse era collegata alla cerimonia dell’offerta del cero e dei censi all’Assunta, rito a carattere religioso, mentre il Palio era una manifestazione popolare di festa ad esso collegata; nei documenti più antichi si trovano solo memorie di questa offerta, tale Palio fu detto “alla lunga” poiché corso per le vie della città e non in un’area definita. Nello statuto comunale del 1310, la corsa è inserita appunto come festa nel giorno dell’Assunta. Il drappellone era di stoffa preziosa, rivestito di pelli di vaio e vi erano riportati gli stemmi dei governanti della città e, nonostante la peste, fu corso anche nel 1348 e nel 1349. A partire dal 1389, la partenza della corsa aveva luogo davanti alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Valli, oggi Chiesa della Compagnia, poi spostata di fronte alla Chiesa del Monastero di Santa Maria degli Angeli, detta successivamente del Santuccio, per motivi di sicurezza cittadina. Nel periodo rinascimentale, i giorni del Palio erano occasione mondana, la città ospitava i grandi nomi dell'aristocrazia, alti prelati e sovrani europei. In questo periodo i signori smisero di combattere personalmente le guerre, assoldando mercenari, e cessarono anche di correre il Palio, iniziando l’uso dei fantini. Il Palio divenne quindi spettacolo da vedere e la corsa occasione alla quale inviare ed esporre i propri colori familiari. Si iniziarono inoltre a correre altri giochi come palii rionali, i Giochi di San Giorgio, i giochi delle pugna, pallonate, cacce dei tori, bufalate (gare con i bufali), e asinate (corse con gli asini). Durante questi giochi si prese a far entrare i figuranti della Contrada ("comparse") in Piazza del Campo con carri allegorici spesso rappresentanti animali esotici o fantastici con significati allusivi al mito e alle virtù nobili. L’ultimo regolamento delle corse alla lunga porta la data del 1529. I cavalli venivano montati da giovani fantini vestiti con uniformi colorate indossate dalle grandi famiglie signorili, successivamente vennero fatti correre scossi (privi di fantino), con un pennacchio, una coccarda che ne indicava l’appartenenza. Il corteo dei Nobili e dalle autorità sfilava lungo il percorso fino al luogo della partenza dove veniva sorteggiato il posto alla mossa. Si poteva scegliere se far partire i cavalli liberi oppure in speciali gabbie. Nei primi decenni del Seicento il Palio compì il processo di trasferimento in Piazza del Campo (forse per motivi di ordine pubblico) e la sua trasformazione in festa popolare. La proposta di correre il Palio in Piazza arrivò ufficialmente al Comune l'11 luglio 1605 dai due Deputati della festa per il Palio d'agosto. Una stampa antica mostra un Palio "alla tonda" corso in Piazza probabilmente il 15 agosto 1633. Il Palio "alla tonda" fu corso in Piazza sempre più di frequente, ma fino alla metà del secolo, sempre nella piazza, si giocava anche le bufalate e inoltre per molto tempo ancora furono corsi altri palii alla lunga per le vie della città organizzati da altri enti o contrade (ne abbiamo menzione ancora nei primi decenni del 1800). Il più importante palio alla lunga rimase però quello in cui si festeggiava la Madonna Regina Advocata Senensium patrona di Siena che venne corso fino alla metà del 1800 e fu sospeso nel 1861 con l’avvento dell’Unità d’Italia poiché la passione dei senesi era tutta rivolta alle carriere che le Contrade fin dal seicento correvano “alla tonda”in Piazza del Campo. Nel 1656, il Palio "alla tonda" a luglio per la Madonna di Provenzano (importante chiesa senese legata a grandi avvenimenti storici cittadini) assunse forma strutturalmente definitiva e cadenza regolare e prese subito carattere di stabilità: dal 1659 lo organizzò direttamente l’ufficio della Biccherna (importante magistratura finanziaria pubblica). I fantini ora avevano un ruolo fondamentale, ed erano considerati dei mercenari. Oltre ad un compenso fisso, gli si diede la facoltà di questuare nella Contrada vincitrice che spesso gli elargiva altro denaro o benefici usanza arrivata fino ad epoche molto recenti e cessata solamente nel 1965 con il famoso fantino Andrea Degortes detto Aceto. Nei primi Palii "alla tonda" le Contrade avevano il compito di procurarsi il loro cavallo, ma per mantenere più eque le possibilità di vittoria, dal 2 luglio 1676 presentarono ciascuna un soggetto, e i cavalli venivano poi assegnati per sorteggio. Dal 1657 si stabilì che i fantini corressero "alla bisdossa" ossia a pelo. Va ricordato che fino al 1793 correvano ogni razza di cavalli, successivamente venne proibito di far correre i cavalli di razza inglese e il cavallo berbero purosangue arabo. Già di questi anni è quindi l'istituzione della "tratta", l'assegnazione a sorte dei cavalli alle Contrade, che si svolgeva al prato di Camollia, fuori le mura cittadine e dopo una corsa di prova il cavallo primo arrivato veniva scartato, così come l'ultimo. Il Settecento fu il secolo dell'introduzione dell’altro palio alla tonda, oltre a quello di luglio. La Contrada dell'Oca, vincitrice nel Palio del luglio 1701, chiese di "ricorrere il Palio vinto" ossia di rimettere in palio la vincita, facendo svolgere a proprie spese un'altra corsa il 16 agosto, per le feste dell'Assunta. Nel 1774 il Comune rese uniformi le organizzazione dei due Palii, e dal 1802 anche quello di agosto fu organizzato a spese della comunità cittadina. Il 16 maggio 1721 fu pubblicato il moderno regolamento del Palio, regolamentati gli orari, la costruzione dei palchi, il corteo che precede la corsa, l'ammontare dei premi e le procedure di iscrizione delle Contrade. Nel 1729, da Violante Beatrice di Baviera governatrice di Siena, fu invece fatta la Nuova divisione dei confini delle Contrade che ne definì anche il numero. Poche furono le modifiche apportate negli anni successivi alla corsa e ai regolamenti. Attualmente le contrade sono 17. La corsa si svolge nella piazza centrale Piazza del Campo, a ogni Palio partecipano 10 contrade tra le 17 totali, scelte a sorte secondo un particolare regolamento che consente la costante rotazione delle partecipanti. Corrono di diritto le 7 contrade che non hanno corso il Palio corrispondente dell'anno precedente, e un mese prima del Palio vengono estratte a sorte le 3 contrade mancanti. Vengono inoltre estratte le altre 7 contrade rimanenti, per stabilire l'ordine di sfilata nel corteo storico; esse parteciperanno di diritto al corrispondente Palio dell'anno successivo. In caso di Palio straordinario, avviene un sorteggio tra tutte le contrade per determinare le dieci partecipanti. Nel pomeriggio, prima della corsa, dal Duomo si forma la passeggiata storica durante la quale sfilano i mazzieri, i figuranti e i cavalieri rappresentanti il Comune e le istituzioni storiche cittadine, oltreché le "comparse" delle contrade. Dopo il corteo storico (alle 19:30 a luglio, alle 19 ad agosto), i fantini escono a cavallo dall'entrone del Palazzo Comunale, ricevono il nerbo (tendine di bue essiccato per sollecitare il cavallo) e si spostano nella zona della partenza, detta "mossa" posta nel tratto precedente alla Fonte Gaia. Dal “verrocchio” palco speciale del palio, il "mossiere", giudice unico della validità della partenza, riceve una busta contenente l'ordine di allineamento ai canapi, due lunghe corde che delimitano la zona di partenza. L'ordine di ingresso è segreto e viene determinato con un meccanismo automatico a estrazione chiamato "fiasca". Per accedere alla zona tra i due canapi la corda posteriore è più corta ed è sorretta da un meccanismo chiamato "verrocchino"; in questo modo viene lasciato uno spazio attraverso il quale i cavalli fino al nono possono entrare. Dei 10 cavalli uno è sorteggiato "di rincorsa" perchè non entra subito ma parte da una posizione arretrata, ed è proprio il suo entrare tra i canapi, già al galoppo, a dare il via alla corsa stessa. Di conseguenza chi decide il momento di inizio della corsa non è il "mossiere" ma il fantino del cavallo "di rincorsa". La capacità del "mossiere" sta nel riuscire a percepire per tempo l'azione della rincorsa e sganciare con un pedale il canape anteriore posto davanti alla linea degli altri nove cavalli con il giusto tempismo; giudice insindacabile è comunque il mossiere stesso. Durante questa fase, i fantini cercano di adottare strategie, porre veti incrociati, tentare di raggiungere accordi. Qui i fantini possono chiedere e cercare collaborazioni o aiuti ad altri fantini. Tutta questa attività è detta "fare i partiti”. Dopo la partenza, per motivi di ordine pubblico, il mossiere lascia la piazza e non assiste alla corsa. Il Palio viene vinto dal cavallo, con o senza fantino (se vince il cavallo con fantino caduto è detto scosso), dopo che per primo abbia compiuto tre giri della piazza in senso orario. Al termine i contradaioli vincitori si precipitano sotto il palco dei Capitani a ritirare il drappellone, che sarà dapprima portato in chiesa (in luglio presso la Collegiata di Santa Maria in Provenzano, in agosto presso il Duomo) e poi conservato per sempre nel museo di Contrada. La Contrada festeggerà a partire dalla sera stessa e per settimane con una serie di cortei e cene nel proprio territorio detti “cenini”.

I Ricciarelli
Nelle spezierie vicino a Piazza del Campo troviamo antichi slogan, affrescati con scritte in oro, che inneggiano le bontà di Ricciarelli, Panforti e altri dolci tipici locali. Ci testimoniano la storia e l’importanza di questo dolcetto alle mandorle di Siena, coperto di zucchero a velo con cuore morbido, fondente in bocca, fresco e umido dal penetrante aroma di mandorle amare lavorati artigianalmente nelle forme e curati nella loro confezione artisticamente.
Alcune sono le teorie e le ipotesi sull’origine del nome e della ricetta. Nella prima ipotesi ( la più accreditata), pare che l’origine dei Ricciarelli risalga al XV secolo; che la ricetta originale fosse araba, a base di marzapane, da cui il nome di “marzapanetti alla senese” o “morzelletti”. La loro lavorazione era tipica dei conventi o nelle botteghe degli “speziali” (le farmacie di oggi) perché erano gli unici luoghi autorizzati a trattare le spezie ed in cui si potevano reperire in grande quantità per aromatizzare i cibi. Il Marzapane, importato dall’Oriente (deve il suo nome alla città birmana di Martaban dal termine arabo mauthaban=scatola per contenere), secondo la tradizione era riposto e donato, come offerta di ossequio, in preziosi cofanetti in occasione di visita alla città di grandi personalità o autorità. In Toscana la Repubblica Marinara di Pisa aveva stretti contatti con queste terre e ne avrebbe importati gli usi e le ricette. Pare che anche i senesi adottarono questa usanza come cita lo stesso Niccolò Machiavelli ne “Il Principe”, che narra della visita di un delegato pontificio, dove i piccoli marzapani vengono offerti da Pandolfo per ossequiare ed ingraziarsi tale parte politica in un momento di grande tensione nella Repubblica Senese. Pandolfo della famiglia Petrucci vissuto nel 1500, periodo in cui Siena aveva perso lo smalto del XIV secolo e si trovava a competere con vicini più potenti sia sotto l'aspetto economico che militare, è famoso per essere pragmatico e per intrecciare affari e politica servendosi anche di personaggi all'inizio ostili ma che, blandendoli e compensandoli generosamente, coinvolge nei suoi progetti legandoli completamente a sé, meritandosi così il giudizio espresso dal Machiavelli: «hanno è principi, et praesertim quelli che sono nuovi, trovato più fede e più utilità in quelli uomini che nel principio del loro stato sono suti tenuti sospetti, che in quelli che nel principio erano confidenti. Pandolfo Petrucci, principe di Siena, reggeva lo stato suo più con quelli che li furono sospetti che con li altri.» (Niccolò Machiavelli – Il Principe, XX.) Il Machiavelli, che con lui ebbe diversi contatti diplomatici e ne apprezzò le capacità di statista, lo descrisse come «un uomo di assai prudenza in uno stato tenuto da lui con grande riputazione, e senza drento o fuora capi nimici di molta importanza per averli morti o riconciliati.» Ecco che i nostri dolcetti hanno contribuito al successo di trame politiche. Il novelliere e commediografo senese Parige racconta invece, in una delle sue novelle, di un personaggio senese, tale Ricciardetto della Gherardesca (da cui il nome Ricciarello) il quale rientrando dalle Crociate nei suoi possedimenti vicino a Volterra, nel periodo di Natale, introdusse l’uso di alcuni dolcetti arabi che ricordavano la forma arricciata delle babbucce dei Sultani, aggiungendo una spolverata di zucchero a velo. Un primo riferimento specifico al termine Ricciarello è recuperato da un lungo elenco di dolci toscani pubblicato nel “Ditirambo di S.B. in onore del Caffè e dello Zucchero” stampato a Livorno nel 1814. Qui troviamo scritto “della lupa i Ricciarelli”, dove il riferimento all’origine senese è dimostrata dall’indicazione del simbolo della città, la lupa per l'appunto. Nel 1891 viene pubblicata la prima edizione de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, primo esempio di ricettario della tradizione gastronomica nazionale. La ricetta n. 629, dedicata alla lavorazione del prodotto in questione, reca nel titolo la denominazione “Ricciarelli di Siena”. Gli ingredienti indicati nella ricetta sono quelli ancora in uso oggi: “zucchero bianco fine, mandorle dolci e amare, chiare d’uovo, odore di buccia d’arancio”. Per quanto riguarda i fattori produttivi si segnala l’utilizzo di alcune tecniche di lavorazione presenti anche in altri dolci tipici senesi di Natale: ad esempio la superficie del prodotto viene cosparsa da zucchero a velo prima di effettuarne la cottura mentre la base è protetta da ostie di amido le quali, terminata la cottura, diventano un tutt’uno con gli ingredienti. Un’altra versione spiega che i dolcetti avrebbero uno stretto legame con il Palio di Siena. I Ricciarelli deriverebbero dai morselletti, venduti per il Palio dell’Assunta a Siena, la cui "carriera", come viene tradizionalmente chiamata la corsa di cavalli mezzosangue in Piazza del Campo, è una competizione fra le Contrade di Siena che si svolge dal 1200 e ancor oggi normalmente due volte l'anno: il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano festa della Visitazione nella forma straordinaria, e il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta Per la festa dell'Assunta Siena diveniva "città aperta". Le catture venivano sospese, i fuoriusciti potevano tornare e andar franchi per la città, merci e bestiame giungevano in gran copia per il grande mercato, le strade si animavano di musici e giullari, mimi e buffoni che intrattenevano la folla; saltimbanchi e forzaioli, cavadenti e guaritori, treccole e baldracche, osti e mercanti offrivano le loro merci e i loro servigi. Si provvedevano cibi e bevande per tutti. Nell'atto di sottomissione e Montelaterone (1205) il Comune si impegna a fornire il vitto a chi porterà a Siena il tributo di cera fina. E' questa la prima testimonianza di un costume che sarebbe continuato nel banchetto offerto dalla Signoria e ai nostri giorni nelle grandi e popolari cene della vigilia imbandite per la città a migliaia di commensali. In un'età storica che viveva, anche nelle città più splendide come fu Siena, la "cultura della fame", la festa fu anche libertà dalle strette misure quotidiane del pane e del vino. La città reperiva, offriva e ostentava cibo e bevande per tutti, vini e carni, confetti e morselletti, biricuocoli e biancomangiari, tutti i diretti antenati dei cavallucci e dei ricciarelli, delle copate e dei panforti di oggi. Nel Marzo 2010 la denominazione Ricciarelli di Siena è stata riconosciuta come Indicazione Geografica Protetta, primo prodotto dolciario d’Italia ad avere ottenuto la tutela europea con tanto di disciplinare di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo della Provincia di Siena. Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuno dei prodotti in entrata ed uscita, con speciali elenchi di descrizione e segnalazione delle quantità prodotte, al fine di garantirne la tracciabilità. Gli ingredienti obbligatori, la porzionatura, la cottura, il legame con l’ambiente, i controlli e le etichettature sono tutte disciplinate ed ordinate da un accurato disciplinare di produzione che comprende anche il logo, classico dell’iconografia senese una balzana con scudo di colore bianco, nella parte superiore e nero nella parte inferiore che rappresenta la città, circondata da un drappo rosso e accuratamente disegnato in linea con la storia e la tradizione del prodotto come riassunto di quanto sopraesposto.

Santa Caterina
Caterina nasce a Siena nel popolare rione di Fontebranda, all'interno della contrada dell'Oca, il 25 marzo 1347. E' la ventitreesima figlia del tintore Jacopo Benincasa e di monna Lapa Piacenti. Caterina ha una gemella, Giovanna, che morirà poco tempo dopo la nascita. Fin da piccola Caterina frequenta i frati Predicatori della basilica di San Domenico, poco distante dalla sua casa. Non sceglie però di diventare suora, sente che la sua missione è nel mondo, ed entra nelle Mantellate o Terziarie domenicane.
Le Mantellate erano donne,soprattutto vedove, che si dedicavano ad opere di carità e si raccoglievano in preghiera ogni giorno nella Cappella delle Volte, nella basilica di San Domenico. Caterina fu una donna molto libera nello spirito e nell'azione, che amò la sua verginità consacrata al suo celeste sposo, Cristo Gesù e venne dotata dal Signore di eccezionali grazie mistiche, tra cui il mistico sposalizio e le sacre stigmate. Essa cercò di riportare la pace all'interno delle famiglie ed alle città, infattifu intermediaria di pace a Pisa ed a Lucca,fra il Papato e la città di Firenze.Inviata ad Avignone come ambasciatrice dei fiorentini, per una non riuscita missione di pace presso papa Gregorio XI, convince il Pontefice e da la spinta per il ritorno a Roma, nel 1377. Nelle lettere ai politici suoi contemporanei essa ricorda che il potere di governare la città è un "potere prestato" da Dio. La politica è la buona amministrazione della cosa pubblica finalizzata ad ottenere il bene comune e non l'interesse personale. Per ottenere questo un buon amministratore deve ispirarsi a Gesù Cristo il quale è l'esempio più alto di giustizia. La giustizia infatti, nella dottrina politica di Santa Caterina, ha un ruolo importantissimo; senza giustizia non c'è pace e se manca la pace viene meno il presupposto che sta alla base della crescita sociale e morale di uno stato. Non avendo studiato, dettava le sue lettere, che sono molte e anche i suoi trattati, in particolare la sua opera principale,ovvero il "Dialogo della Divina Provvidenza", terminato nel 1378, due anni prima della morte. Non aveva frequentato nessuna scuola e la sua cultura si formò piuttosto da autodidatta. Toccò tutti i punti della teologia: la Trinità, Gesù Cristo, la Chiesa, i sacramenti, il sacerdozio, i religiosi, la famiglia, la vita spirituale. Muore a soli 33 anni, completamente consumata dal suo amore per la Chiesa, sarà canonizzata nel 1461 dal papa senese Pio II. Sarà sepolta nel cimitero di Santa Maria sopra Minerva. Tre anni dopo le sarà staccato il capo per portarlo a Siena. Quel che resta del corpo, smembrato per farne reliquie, è nel sarcofago sotto l'altare maggiore. Nel 1939 Pio XII la dichiarerà Patrona d’Italia insieme a Francesco d’Assisi. Nel 1970 avrà da Paolo VI il titolo di Dottore della Chiesa e, infine Giovanni Paolo II, nel 1999, l’ha proclamata Patrona d’Europa insieme a S. Brigida di Svezia e S. Benedetta della Croce (Edith Stein).E' anche la protettrice delle infermiere e viene festeggiata nel giorno della sua morte, il 29 aprile. Santa Caterina da Siena ha ispirato numerosi artisti che l'hanno ritratta il più delle volte con l'abito domenicano, la corona di spine, reggendo in mano un cuore o un libro, un giglio o il crocefisso o una chiesa. Molti pittori la raffigurarono anche nei fantasiosi racconti della sua vita, come,ad esempio, il matrimonio mistico, che si distingue da quello di Santa Caterina d'Alessandria, perché in questo caso il Cristo è adulto.